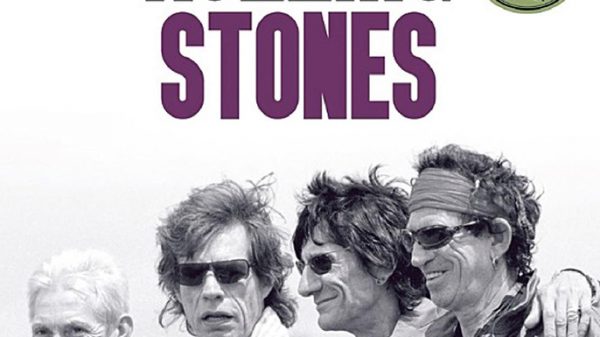Il cinema italiano, cui negli anni Ottanta assestano un colpo non da poco le televisioni private, rinasce nel primo quinquennio del Duemila esattamente da quel genere che nel dopoguerra lo aveva reso materia viva, riempendo le sale e sfidando la penna dei critici più autorevoli, per lo più ostili al cinema cosiddetto “popolare”. Serpeggiava insomma un certo snobismo, si alzavano muri e senza mezze misure si denigravano quei film di genere che di recente sono stati riscoperti e riabilitati a livello internazionale. Ed è in quelle pellicole che scava a piene mani il cinema italiano attuale, dopo un lungo bagno di umiltà e una volta ricollocato il pubblico in quella piramide che Ugo Pirro, uno dei più importanti sceneggiatori del nostro cinema, aveva chiamato in causa per descrivere l’ingeneroso gap tra spettatore e critico.
Oggi si torna dunque a scommettere sul genere, staccandogli di dosso le etichette superficiali e abbattendo finalmente i confini tra cinema commerciale e d’autore che erano stati stabiliti da quella critica miope cui si deve, tra le altre, la demolizione d’un Leone, d’un Argento, d’un Petri, d’un Di Leo o d’un Lenzi.
E, mentre si contemplano il genere e se ne dissotterrano le radici, sbucano fuori parecchi sottogeneri a ingemmare la nuova stagione del cinema italiano, incline nuovamente alla sperimentazione, alla contaminazione, al confronto con inedite forme espressive. È il caso di Gabriele Mainetti, classe ’76, che in “Lo chiamavano Jeeg Robot” (2015) già collaudava l’approccio autoriale sul solco del genere, eludendo la formula filmica unica, immettendovi estro e arditezza straordinari, prendendosi tutti i rischi cui va incontro il grande cinema quando non sgattaiola dall’ambizione d’essere popolare. “Freaks out”, nelle sale cinematografiche dal 28 ottobre dopo una lunghissima e complessa lavorazione, ratifica il talento, a sei anni dalle avventure del suo supereroe disfunzionale dal cuore d’acciaio, di un Mainetti che calca ancora le strade del cinema di genere. Il soggetto originale di Nicola Guaglianone, co-sceneggiatore insieme al regista, guarda con devozione al cult movie “Freaks” (1932) di Tod Browning, ma la pellicola compie la prodezza, di matrice realistica, di calare i linguaggi d’oltreoceano del passato, e persino quelli attuali, in un contesto distintamente italiano.

È il 1943 e Roma è occupata dai nazisti. Quattro freak dotati di superpoteri si esibiscono nel bizzarro circo Mezza Piotta di Israel (Giorgio Tirabassi) dove “l’immaginazione diventa realtà e niente è come sembra”. Sono il raffinato uomo lupo Fulvio (Claudio Santamaria), Cencio il romantico incantatore di insetti (Pietro Castellitto), il nano magnetico dal cuore puro Mario (Giancarlo Martini) e la giovane elettrica Matilde (Aurora Giovinazzo). Una comune diversità destinata presto a sfumare o, meglio, a condensarsi nella straordinarietà che può attenere a ciascun essere.
A sradicare quel presente che mescola mentiti orrori e reali magie la guerra, col suo carico di bombardamenti e rastrellamenti, col suo piglio sfrontatamente disumano. “Noi senza un circo siamo solo una banda di mostri” – riconoscono gli eroi non senza macchia di Mainetti. Non rimane dunque che affidare i pochi risparmi a Israel e accarezzare il sogno americano.
Parallele alla vicenda dei freak si dipanano le trame incompatibili d’una altrettanto eccentrica brigata partigiana e del fenomeno da baraccone per eccellenza: il nazismo. Da una parte le scorribande della Resistenza, dall’altra il delirio dello scienziato, tanto malvagio quanto fragile e frustrato, Herr Franz (Franz Rogowski): omaggiare il Führer d’un pugno di superuomini per salvarlo da quella fine ch’egli presagisce sotto l’effetto ipnotico dell’etere.
Quando i nazisti catturano Israel, quei quattro saltimbanchi dai riflessi pop, sputati via da un mondo che non gradisce gli scherzi della natura, devono arrangiarsi e cercare lavoro altrove. Ad attirarli, ingenui come sono e per questo ancor più incantevoli, è la magnificenza del Zirkus Berlin di Franz. Fa eccezione solo Matilde, un passato agghiacciante alle spalle e il desiderio di ritrovare Israel, verso il quale nutre una profonda riconoscenza.

Queste le coordinate narrative del crogiolo di generi degno del miglior Neorealismo che è l’incredibile “Freaks out”: fantasy, peplum, western, commedia all’italiana; e a chiamare in causa i sottogeneri l’elenco potrebbe considerevolmente allungarsi. Mainetti mette in moto una macchina gigantesca, che richiede i suoi tempi, capace di procurare piacere agli spettatori e al contempo offrire loro notevoli spunti di riflessione, nel fortunato incontro di storia e finzione in virtù del quale i generi si contaminano, si profanano se necessario.
La regia, sontuosa come nel Jeeg, mescola visionarietà e crudo realismo. Si immortalano scene testualmente epiche, su cui incide non poco l’impulso fotografico di Michele D’Attanasio, e poi ci si sofferma con rigore sul particolare, allo sfavillio del quale concorre la destrezza d’un cast d’eccezione che condivide la scena surreale tessendo fili di relazioni tanto impercettibili quanto potenti. Intanto la musica, scritta a quattro mani da Gabriele Mainetti e Michele Braga, lungi dal costituire un mero tappeto musicale, scandisce le aritmie della narrazione da kolossal hollywoodiano. I mostri con cui è necessario fare i conti, sostando dentro uno scenario marvelliano e talora dondolando tra la tradizione picaresca e il cinema sociale, non sono né i freak né i partigiani storpi, mutilati e degni discendenti, nei meditati perimetri di Mainetti, del protagonista d’un poliziottesco all’italiana a caso. Il nazismo ha mostrato il vero volto dell’orrore, per ritrarre il quale non serve scadere nello splatter, che pure non stonerebbe con la pellicola: basta spargere le abominevoli empietà dei seguaci di Hitler, storicamente e senza indulgenza corresponsabili, lungo tutti i 141 minuti del film. Ché dell’odore nauseabondo di quelli sa persino la Roma dal volto onirico che tenta sulla sponda del Tevere, come nel Jeeg, di rialzare la testa.
Risolutiva, ai fini della storia, la trasformazione di Matilde in chiave umana oltreché supereroistica. E, mentre pareggia i conti col destino e folgora la spietatezza, la fanciulla effonde una eccezionale sensualità. Salvo ritrovare altrove, magari nel lancio dalla catapulta insieme al suo Cencio, ora che gli altri freak “reggono il moccolo”, l’innocenza d’un sentimento ancora tutto da scoprire. Gabriele Mainetti ha nuovamente dimostrato di aver appreso, con umiltà e profondo rispetto, la lezione d’una cinematografia di genere che – si rassegni certa critica – sa mischiare con disinvoltura esigenze commerciali e autoriali. Non si crede nella ricetta unica, nella soluzione a portata di mano per dare nuova linfa all’ispirazione e fare ancora del buon cinema. Non si cercano percorsi rettilinei, piuttosto si percorrono tratti di strada tortuosi con la spregiudicatezza e la fantasia necessarie a divertirsi. E divertire.
La leva registica cui appartiene Mainetti, del quale “Freaks out” conferma la vocazione, riesce pertanto a innovare, nella pluralità delle specificità tecniche e artistiche, le forme del racconto cinematografico sul solco di quella tradizione che fino alle soglie Settanta ha avuto la sua più prolifica stagione.