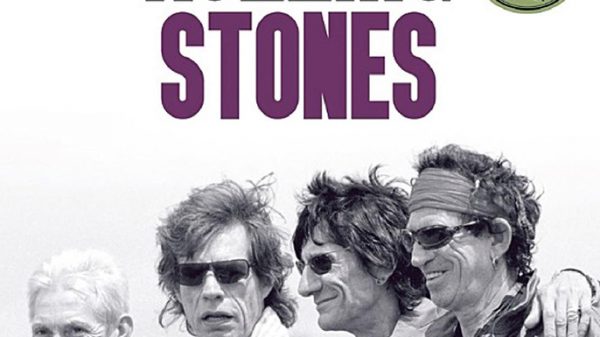Uscito nelle sale il 27 gennaio, “La fiera delle illusioni – Nightmare Alley” di Guillermo del Toro precede di pochissimo il “Pinocchio” in stop-motion per Netflix e segue quel capolavoro, “La forma dell’acqua – The Shape of Water”(2017), che fece incetta dei premi cinematografici più prestigiosi.
Si entra al cinema, come dire, confortati dal palmarès del regista di Guadalajara. Il film è peraltro la seconda trasposizione sul grande schermo, dopo quella di Edmund Goulding del ’47, dell’omonimo romanzo di William Lindsey Gresham scritto nel 1946.
Una combinazione sulla quale si punta senza pensarci troppo. E i 150 minuti della pellicola ti danno ragione. Su Guillermo del Toro pare si possa tutte le volte scommettere.
La storia
1939. Stanton Carlise (Bradley Cooper) occulta un cadavere nella propria casa, la brucia e va via. Con l’intento di ricominciare.
Si imbatte nel luna park di Clem (Willem Dafoe) e lì inizia la sua carriera nel mondo delle illusioni, sgraffignando il mestiere e cucendoselo addosso. Senza scrupoli e con una brama di soldi e potere che letteralmente lo divora.
Non che il mondo dei giostrai fosse alieno dalla ferocia, ma Stan, già freddo innanzi al dolore di disperati imbottiti di alcol e droga perché diventino perfetti fenomeni da baraccone, valica i confini dell’umanità e incentra sulla menzogna più crudele tutta la sua nuova esistenza.
Non gli servono dunque i consigli della chiaroveggente Madame Zeena (Toni Collette) e del marito Pete (Antonio Sanna) sulla gestione del mentalismo, non gli servono quelli conditi d’amore della mite Molly (Rooney Mara), un tempo donna elettrica ora fedele compagna di vita del disumano lestofante.
Stan porta negli occhi il desiderio che non conosce perplessità e corre veloce, con la presunzione di non schiantarsi mai.

Il noir come specchio della realtà
“La fiera delle illusioni” è popolata da un mucchio di personaggi, più o meno necessari allo sviluppo della trama eppure tutti provvisti di una magnificenza, visiva e semantica, che coopera al grande affresco di vita cui il noir di Guillermo del Toro non si sottrae.
E, in un caleidoscopio di immagini dai colori caldi e dalle intermittenze che convengono ai luna park, si compie il destino d’un individuo che assurge a metafora della bramosia d’ogni tempo, dentro i margini della quale il capitalismo, ça va sans dire, risulta essere la pianta carnivora per eccellenza.
Estorcere fiducia e denaro è un gioco di prestigio a tutti gli effetti: le menzogne si spacciano per verità, ci si approfitta del dolore altrui, si vendono a caro prezzo le illusioni.
I rimandi alla realtà sono manifesti e il regista messicano ne è consapevole. Come, e ancor più, è consapevole dell’irrappresentabilità del mondo fatato d’una fiaba a lieto fine.
Significherebbe accumulare menzogne su menzogne. Il cinema di genere, cui del Toro da sempre strizza l’occhio, e in particolare horror e noir, sembrerebbero dunque i migliori interpreti della meno edulcorata verità.

Il circo nel cinema
“La fiera delle illusioni”, a pochi mesi dall’uscita di “Freaks out” di Gabriele Mainetti, si serve d’un mondo circense che amplifica ed eventualmente adorna il triste circo della realtà.
Il cinema sa essere del resto la migliore lente d’ingrandimento di uomini e cose che si deformano semplicemente apprestandosi a vivere.
Il cinema sa riprodurne le asimmetrie e il più delle volte le investe d’una inedita e consolante bellezza.
Al di qua delle nostre frontiere è inevitabile rammentare “La strada” di Federico Fellini, quella meraviglia d’energia e spettacolo che coglieva l’orrido e, senza reconditi artifici, lo trasformava in attrattiva, strumento sempre di decodifica del reale.
Così Molly assimila la lezione di innocenza di Gelsomina, e Stan risulta un altrettanto terribile Zampanò cui il regista, in luogo del pianto disperato in riva al mare, riserva uno scenario dantesco immaginato attraverso quel disgraziato volto in primissimo piano che suggella la circolarità, equanime se vogliamo, del male.

Una enorme galleria di storie e personaggi
Il protagonista si trova catapultato dall’Olimpo all’inferno in un volgere di anni che registicamente corrispondono a due ore e mezza di pellicola.
Si riconosce il merito a Guillermo del Toro di aver scelto abilmente il nutrito cast e di aver congegnato, insieme alla moglie Kim Morgan, una sceneggiatura che potesse sostenere il buon ritmo della narrazione.
Gli ornamenti, incorniciati da quegli anni Cinquanta che richiamano il neorealismo, sono di gran pregio e dimorano per lo più nei singoli bozzetti che compongono il quadro d’insieme.
Dai numeri della psicologa Lilith Ritter, una Cate Blanchett in Fatal Attraction style, agli squilibri perniciosi del ricco Ezra Grindle (Richard Jenkins), fino al triste quadretto del giudice Kimball e della moglie alle prese, per il tramite del perfido Stan, con lo spirito del figlio defunto.

Violenza a perdita d’occhio
Ovunque si posi lo sguardo è possibile individuare le fragilità e le spietatezze d’un mondo del quale il circo rappresenta francamente il volto migliore. Se non altro il più esplicitamente artefatto, pertanto il più onesto.
Siamo nel ’39, alle porte del secondo conflitto mondiale. L’Uomo Bestia che divora il pollastro ripugna lo spettatore alla stessa stregua dei mostri, quelli sì reali, che hanno divorato e che tuttora divorano gli esseri umani. È lo sterminio d’oche di Eugenio Montale, è sempre il medesimo scopo: soddisfare il palato di pochi.
Guillermo del Toro ci conduce però fino all’ultimo giro di giostra, quello in cui si perde tutto. Va così la vita, o così dovrebbe andare. E rimane la più complicata tra le fiere delle illusioni.