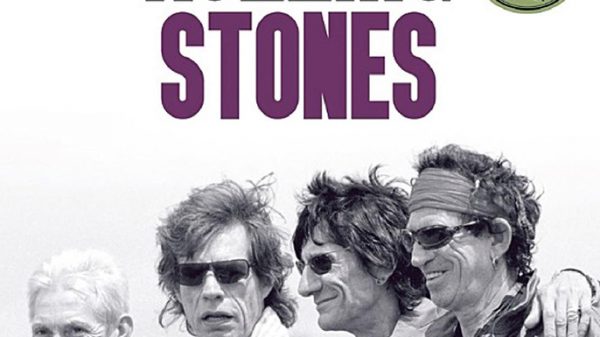Dal 12 aprile su Amazon Prime il noir italo-francese di Michael Zampino “Governance – Il prezzo del potere” con l’inappuntabile Massimo Popolizio nei panni di uno spregiudicato manager aziendale del settore petrolifero. Sotto la lente d’ingrandimento un mondo che il regista, alla sua seconda prova dopo “L’erede” del 2011, ben conosce per esperienza professionale diretta e dentro il quale, con la macchina da presa, entra agevolmente dai vetri delle finestre o girando per i corridoi asettici ove le presenze umane sovrintendono all’impiego di quell’oro nero che garantisce utili esagerati. Lì, tra il bianco dell’arredo e la geotermia, il fotovoltaico atti a garantire un’indispensabile svolta green che lavi via qualche contaminazione di troppo, v’è ampio spazio per l’ambizione, l’arrivismo, la ferocia. Renzo Petrucci è pertanto l’allegoria di tutta quanta la disumanità alla quale molto spesso si ricorre in nome del profitto, di quel dio denaro per il quale si possono commettere i più efferati crimini.
Fosse stato un film essenzialmente d’azione, “Governance” avrebbe potuto sì restituirci la visione d’insieme di un universo dai mille lati oscuri, ma per traslocare lo sguardo dello spettatore sulle umane miserie occorreva, dall’inizio alla fine, una costante virata sui singoli personaggi, una virata che fissasse ogni sguardo, ogni posa, finanche ogni respiro. E tutto ciò è stato reso possibile dall’abile lavoro di scrittura degli sceneggiatori (Michael Zampino, Heidrun Schleef e Giampaolo Rugo), cui non dovevano sfuggire – come non sono sfuggiti – i codici di certa criminalità d’alto borgo, e da una regia che asciuga, lavorando di cesello sull’essenziale, perfino asservendo la trama all’esigenza di operare per segmenti. E sono interessanti scene, sulle quali la macchina da presa si sofferma appena il necessario eppure con inusitata durezza, a dipingere l’affresco di quella realtà cui sono preclusi i colori pastello e dentro la quale persino l’ecosostenibilità è un’elegante bugiarda facciata.
La pellicola è parzialmente un flashback che segue la scena del crimine, replicata sbrogliando fonicamente quei dialoghi di cui lo spettatore, dapprima dietro la posizione defilata di Michele Laudato, (Vinicio Marchioni), non aveva prestato orecchio. Sono vuoti e pieni, quelli del sonoro cucito sulla disposizione spaziale dei personaggi, che hanno un ruolo semanticamente vitale. Del resto le partite che si giocano in una multinazionale come la Royal non si prestano all’ostentazione delle voci: pesano piuttosto intenzioni e allusioni scortate dal solido tappeto musicale di Sartoria Sonora. Parimenti riguardosa della misura e dell’asciutezza di cui si fregia Governance anche la fotografia di Stefano Paradiso.
La morte dell’ingegnere francese Viviane Parisi (Sara Denys), destinata a sostituire nel ruolo di Direttore generale l’inquisito Petrucci, è l’accomodamento dei fatti quando la realtà si mette di traverso. E vale il prezzo di qualche noia con un’ispettrice arguta: nulla che non si possa accomodare, appunto, quando si siede ai tavoli del potere. La mina vagante sarebbe quel Laudato tormentato dagli occhi imploranti di Viviane, poco prima che l’automobile nella quale era incastrata prendesse fuoco. Ma un meccanico che ha frequentato la galera baratta senza battere ciglio il silenzio con una stazione di servizio. La moglie alla cassa, le spazzole dell’autolavaggio, il futuro assicurato ai figli: cosa sarà mai, dunque, uno scampolo trascurabile di verità?
E la verità può facilmente andare a nascondersi dentro la grande casa con le tele incastonate alle pareti di Petrucci. Pure le dinamiche familiari, riacquistata la tranquillità professionale, si accomodano. La fisioterapia per la figlia affetta da spina bifida, il recupero del rapporto con la moglie e, se ti muore un cane, te ne puoi sempre comprare un altro. I peggiori criminali sanno essere padri e mariti devoti.
Così che il lieto fine della storia sembra essere un compleanno. La sorpresa un romanzo, “La fine dell’oro nero”. Dentro, il DVD con le immagini di quella notte registrate dal sistema di videosorveglianza. Ché la fortuna gira, ché una volta sniffato il mondo di appalti e contratti non ci si accontenta del golf. Validissima ragione, il pensierino recapitatogli in busta chiusa, per sprofondare nella poltrona con un ingente carico di pensieri e neppure uno straccio di senso di colpa: il ritratto del peggiore cinismo.
Egregia la prova attoriale di Popolizio, cui si addice oltremodo il ruolo del cattivo; sgradevole addirittura nell’avventarsi su un tagliere di salumi e formaggi. Altrettanto convincente quella di Marchioni, l’infame inatteso che getta ulteriore disprezzo sul dentro e fuori di un mondo nettamente irrecuperabile. Zampino dirige con cura il suo cast, consegnandolo intanto alla comune ingordigia: ciascuno divora ed è a sua volta divorato. La tragedia risiede nell’accettazione prima e nell’adattamento poi all’immutabilità del male.
Sottratte alla putredine morale cui si avviticchia Governance, le donne sembrano costituire quella confort zone ove dimorano incolpevolezza e ingenuità. È come se abitassero certe storie senza averle mai realmente apprese. Capita loro di cambiare il corso degli eventi, senza volerlo. O di salvare una vita, tra uno scontrino e l’altro in quella stazione di servizio costata un prezzo altissimo. È davvero ingenuità o piuttosto connivenza?
Da qualunque angolatura si guardi alle cose, Zampino è come se raccomandasse cautela. Si diffidi dell’opulenza, si diffidi dei vetri senza aloni, delle multinazionali petrolifere, degli utili a molti zeri. Si diffidi, infine, dell’uomo. Affamato, disinibito, manifestamente imperfetto. Ogni limite, nel 2021, sembra essere stato superato. Senza leggi etiche – sosteneva Margherita Hack – ci sarebbe il branco e non la società. E di quel branco Governance è un’onesta istantanea, senza ritocco, senza neppure un’impercettibile variazione cromatica.