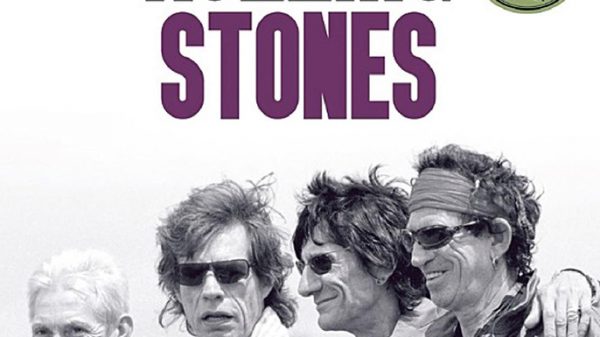Recensione
Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017, “Le otto montagne” è il film diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch uscito nelle sale italiane il 22 dicembre.
Si direbbe una storia d’amicizia nata durante una vacanza estiva e sopravvissuta al tempo, agli strappi della vita. Ma dentro a questa pellicola dal gusto retrò v’è di fatto il recupero d’una esistenza semplice nei luoghi montani incontaminati che, a dispetto delle asprezze e dei pericoli, trasudano quiete, energia, libertà.
Pietro è un bambino di città, Bruno vive in un paesino di montagna. I luoghi dell’infanzia hanno la prerogativa di dimorare per sempre nel cuore di chi li ha vissuti con quella spensieratezza che non appartiene agli adulti.

Bruno non ne contempla il distacco, Pietro ci torna quando può, quando sente di doverci tornare.
E lì sfumano i conflitti col mondo oltre quelle vette, il mondo dei palazzi, delle strade che rigurgitano automobili, degli automobilisti impazziti, della fretta che ti impedisce persino di fermarti a respirare. Lì tutto assume le sembianze di un tempo sospeso, di una vita da costruire con le proprie mani, come una casa di mattoni, di un mondo tutto ancora da scoprire.
I legami che lontano dalla montagna si sfilacciano valicano i confini dell’esistenza e, passo dopo passo, si rinsaldano. Chi rimane percorre i medesimi sentieri di chi non c’è più: ci si ritrova, ci si rincontra, come non era accaduto mai.

Pietro e Bruno risultano interscambiabili nella relazione con i genitori del primo. Nessuna gelosia, piuttosto la possibilità di afferrare l’ultimissima chance, quando ormai non si può tornare indietro.
I rapporti con i rispettivi padri sono tormentati, risentono del divario generazionale sì, ma pure del carattere indomito dei figli. Ché si può essere indomiti, come Pietro, nel voler rompere con la tradizione e indomiti, come Bruno, nel volerla perpetrare a ogni costo.
Salta nell’uno e nell’altro caso il banco delle relazioni familiari, sentimentali, amicali, coi confini labilissimi a separarle e contraddistinguerle.

La regia non punta sull’azione. Ingloba l’inerzia provvidenziale dei paesaggi, restituiti dalla pregevole fotografia di Ruben Impense cullati dalle musiche sorprendenti di Daniel Norgren, e la licenzia inanellando inquadrature che attraversano molti generi cinematografici, in quel 4:3 che lascia si erga, imponente e solenne, la natura.
Il lavoro di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch richiama numerose pellicole, per affinità di storia o di ambientazione. Qui tuttavia a compiere il salto di qualità, fatta salva l’eccellente prova dei piccoli Luca Barbiero e Cristiano Sassella, è l’interpretazione dei due protagonisti da adulti: Luca Marinelli e Alessandro Borghi.
Non era facile restituire allo spettatore i moti impercettibili dell’animo, obbedendo contestualmente ai silenzi d’un tempo e d’un luogo alquanto avari di parole. Non era facile spargere gioia, paura, sollievo, dolore, rimorso e tutta la gamma delle emozioni, in una scala cromatica infinita, centellinando le frasi, molto spesso spezzandole, lasciandole appese e in balìa dell’altrui capacità di afferrarle.
Se la prima parte del film, che si intuiva apparecchiasse la tavola al futuro, scivola via veloce, la seconda risente dei viaggi, dei ritorni, delle assenze, ancor più dei conflitti di un mondo che si apre all’amore, al lavoro, al destituente senso del dovere. I minuti non pesano, qualcuno però lo si sarebbe potuto senz’altro sacrificare alla causa della scorrevolezza in termini puramente narrativi.

Ché “Le otto montagne” è un film da guardare con gli occhi sbarrati dal primo all’ultimo istante, non fosse altro che per quel magnifico mondo che ti si presenta innanzi. Poi chiaramente subentra la comparazione che non vorresti mai fare: quella tra la Torino di Pietro, e di tutti noi, e le montagne dell’alpeggio di Bruno, delle mucche da mungere, della vera arte casearia, del buon vino e dell’aria buona da respirare.
Qui la storia d’una amicizia letteralmente si perde tra i rivoli della mestizia che deriva dalla consapevolezza di abitare la metà del mondo sbagliata.
La scelta di Pietro si colloca allora sulla linea mediana, compendiata dal sorriso durante una partita a calcio coi bambini del Nepal. I colori della terra si mescolano al rosso delle maglie. E sono caldi, chiacchieroni, affabili, squisitamente popolari.

L’intransigenza di Bruno è invece un prezzo troppo alto da pagare per chi resta, ma pare sia l’unica strada percorribile per l’ultimo uomo d’un mondo che non c’è più. È bianco dappertutto. Ed è silenzio. È pace. Nessun dolore, solo una profonda malinconia che il timido sole svela, quando s’appresta a sciogliere la neve. Quando lenta avanza l’estate che per Pietro non sarà mai più la stessa estate.