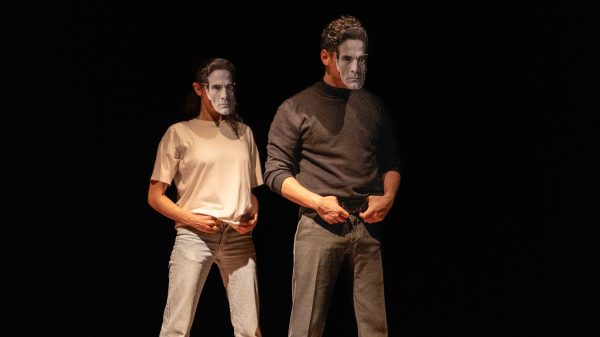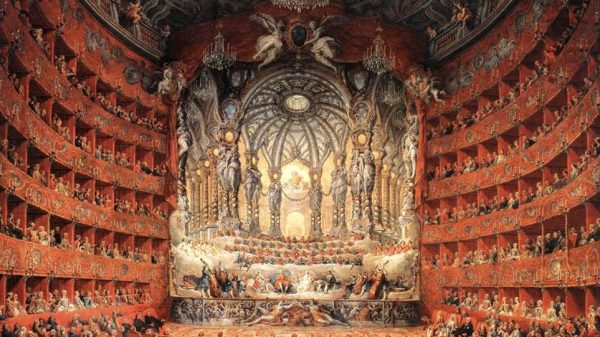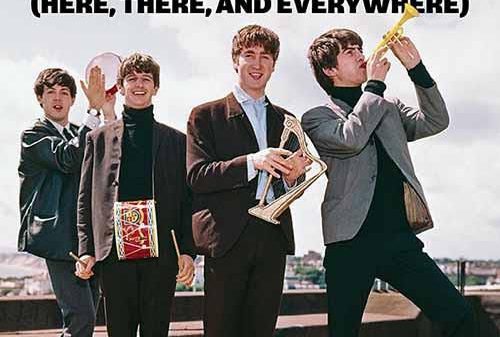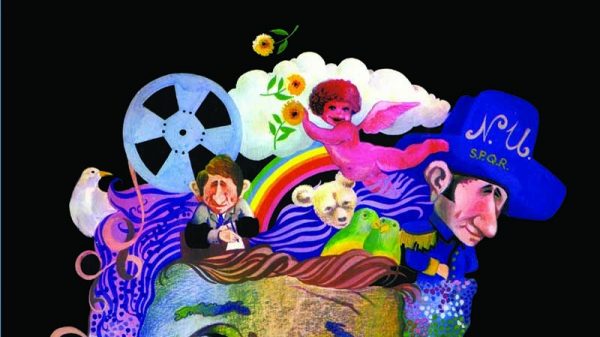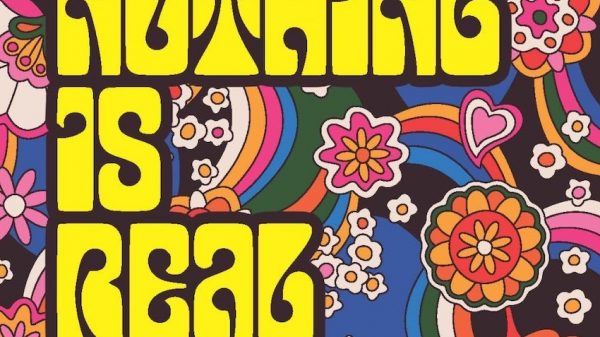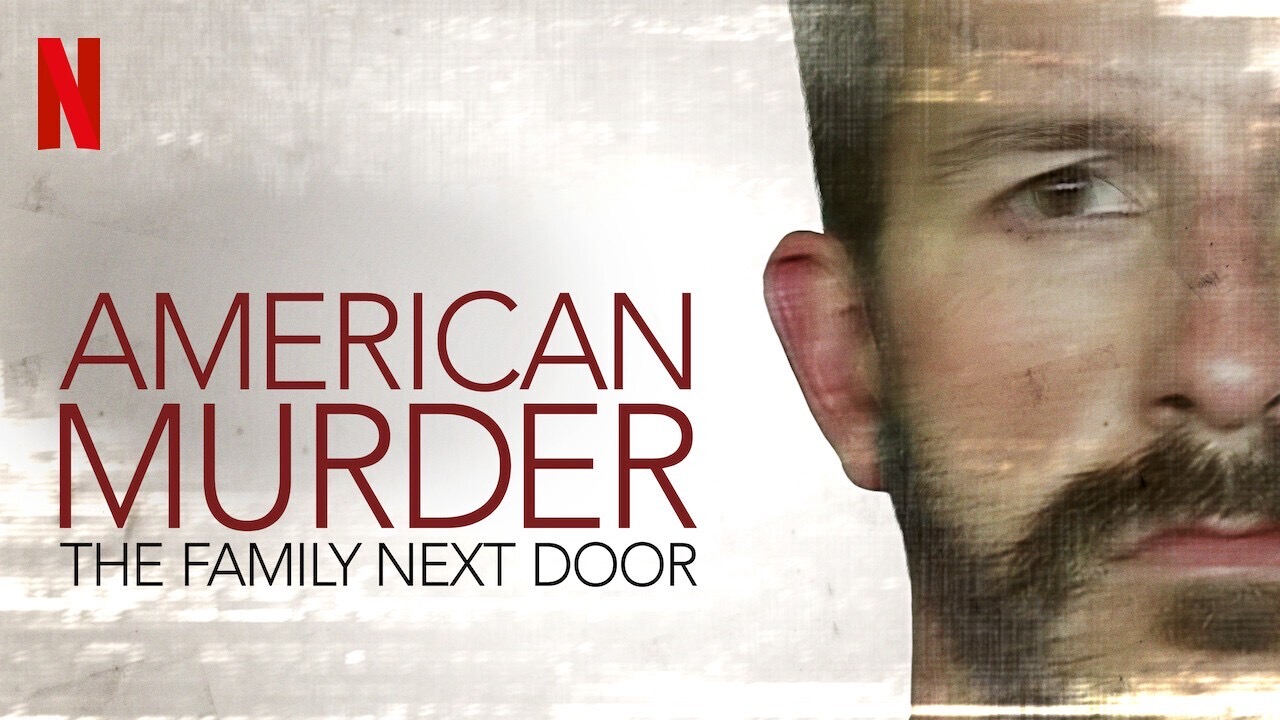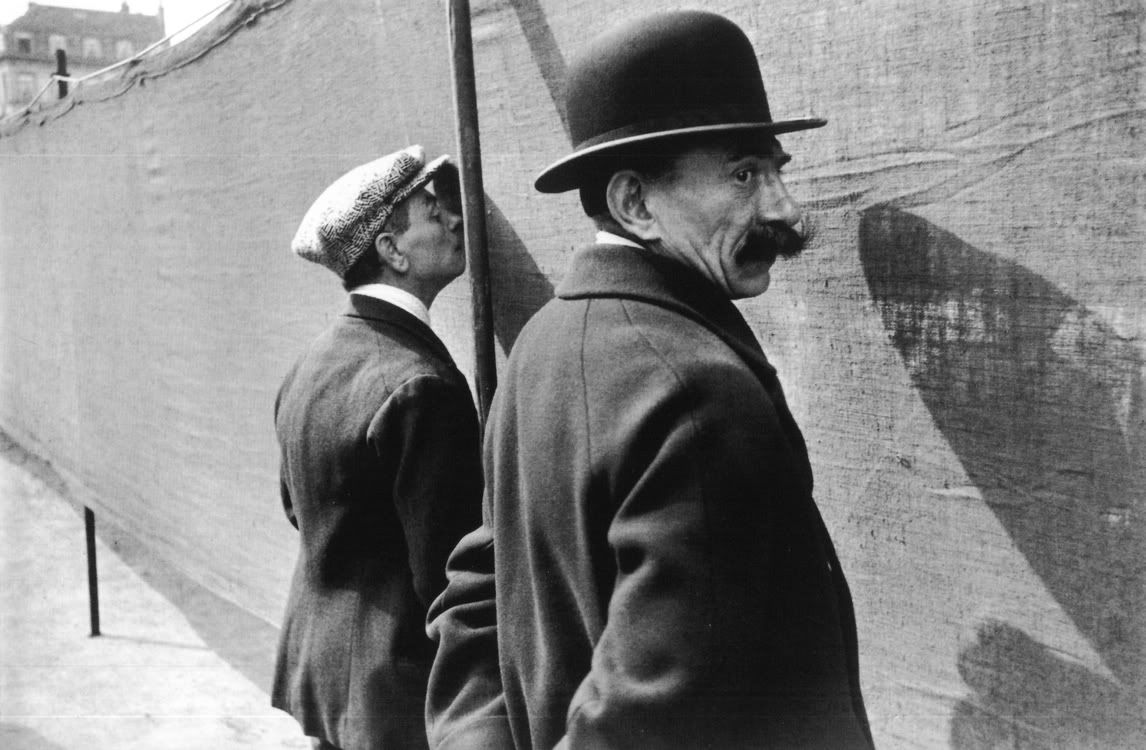La recensione del film ora su Netflix … e una riflessione
È già alquanto complesso il fenomeno diffuso della strumentalizzazione del dolore in TV. A volerlo indagare ci si imbatte, volenti o nolenti, nello spettacolo, nella retorica, nella morbosità e nella perversione d’una società che sembra cibarsi delle tragedie altrui. Per ridimensionare le proprie, forse.
Si segue il filo sottilissimo della narrazione empatica e al contempo, più o meno consapevolmente, si educa il telespettatore al cinismo, all’imperturbabilità. Così che un crimine efferato tiri l’altro e come a reti unificate, da mattina a sera, si rigiri il coltello nella piaga.
I telegiornali stessi, tra un virus e una guerra, non perdono occasione di metterti al corrente di quel fatto di cronaca nera che terrà banco per settimane nei programmi di intrattenimento. Roba da fare andare di traverso un pasto persino ad Hannibal Lecter.
Allora ci si chiede: dove finisce il diritto di cronaca e comincia lo show? Non è accanimento mediatico questa violazione della privacy di vittime e carnefici? Nessun reato si configura?
E ahimè sulla falsa riga della TV pare procedano le case produttrici di docu-film che spiano dal buco della serratura l’orrore.
“American Murder – La famiglia della porta accanto” (2020) di Jenny Popplewell, distribuito da Netflix, in un solo mese è stato visto da oltre 52 milioni di spettatori. È nientemeno che una pellicola realizzata con immagini reali. Non uso volutamente il termine found footage perché preferisco continuare ad associarlo nella mia mente al recupero del metraggio preesistente in “Livre d’Image” di Jean-Luc Godard. Niente superbia da radical chic, piuttosto l’umile tentativo di ridefinire qualche confine cinematografico.

La storia di “America Murder” coincide con la cronaca della tragedia familiare cominciata nell’agosto del 2018 quando a Frederick, in Colorado, scomparvero la trentaquattrenne incinta Shanann Watts e le sue due figlie. Ne dà l’allarme un’amica della giovane donna. Poi è tutto un susseguirsi di indagini che conducono all’unico probabile e presumibile responsabile di quelle sparizioni che già odorano di morte: il marito Christopher Watts.

Una storia di violenza dunque. È l’orrore che si insinua in una villetta a schiera circondata dal verde. È il sogno infranto di una donna. È lo sgretolarsi, furtivo e lento, d’una famiglia all’apparenza felice. Perché se, in mezzo a tanta efferatezza così largamente esibita e alla quale ci si è più o meno assuefatti, c’è qualcosa sulla quale davvero riflettere questa è proprio la discrepanza tra quel che appare e quel che realmente è.

L’universo social restituisce troppo spesso una felicità posticcia. È un gioco di illusioni che si gioca attraverso le foto, i video, le parole. Vince chi resiste fino alle fine. La famiglia Watts inequivocabilmente ha perso.

Ma chi perde deve per forza subire il saccheggio, a posteriori, della propria esistenza? Gli scambi di messaggi tra Shanann e l’amica, tra Shanann e il marito cosa aggiungono a una vicenda per etichettare la quale basterebbero poche lapidarie parole? Passare a setaccio una storia vera, di quelle che fanno male solo a ripensarle, ha per caso una funzione didascalia che a me in questo momento sfugge? E perché 52 milioni di spettatori (me compresa) sono attratti da una realtà così tristemente atroce?
Alla vita vera si aggiunge vita vera, ed è un abisso sempre più profondo. Mentre da dietro un monitor si pratica la finzione. In buona sostanza, un delirio. Il caos dentro al quale ci dimeniamo ogni santo giorno.
Di contro, dove è andato a nascondersi il piacere di scrollarsi di dosso per un istante la realtà e spiccare il volo, anche solo per illudersi che un altrove sia ancora possibile?