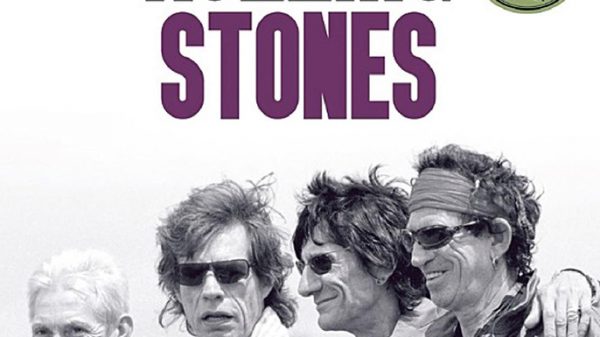Un ritorno privo di funambolismi quello del regista Silvio Soldini, che a “3/19” assegna il compito di scavare a fondo nel cuore di una donna, mirando a un orizzonte credibile di rinascita ottenuto da una scomposizione del colore degna del miglior pointillisme, coi piccoli punti a costituire stadi vitali prodromici del cambiamento.
Non occorreva pertanto spingere sul pedale dell’acceleratore in termini di azione e Soldini dimostra di conoscere a fondo i tempi che necessita un dramma intimo, senza tuttavia scadere nella lentezza, piuttosto scortando le aritmie della protagonista e, di rimbalzo, quelle delle vite che le camminano a fianco.
Camilla, interpretata da una Kasia Smutniak in evidente stato di grazia, è una avvocatessa votata al prestigio professionale. Si chiamerebbe in causa l’ambizione, la sete di denaro, persino la vanità, se non ravvisassimo nei suoi occhi quella profonda sofferenza da eludere semplicemente ingombrando i giorni, azzerando i vuoti che stuzzicano i pensieri meno sostenibili.
Il lavoro scava allora abissi sul presente, ma sbarra la strada al passato. Un matrimonio andato a male, una figlia (Caterina Forza) emotivamente distante, una pseudo relazione che non reclama ore e particolare diligenza risultano il prezzo da pagare alla calma apparente d’una esistenza manifestamente a metà. La tirannia del tempo a pesare sulla bilancia molto più del bisogno di trattenere e sminuzzare i giorni, da quando sanno fare paura.

Il fischio del treno per Camilla è un’assenza, a richiamare altre assenze.
Da un incidente stradale consegue la presa di coscienza, in chiave deterministica, dei legami che intercorrono tra individui.
Il terzo corpo sconosciuto del 2019, quello di un giovane migrante, giace all’obitorio ed è l’effigie d’un mondo che si nasconde a tal punto da cessare d’esistere, impattando nella pellicola con gli spazi opulenti entro i quali la protagonista prova a nascondere sé stessa, rinunciando di fatto a vivere.
Camilla non ricorda il colore del semaforo pedonale al momento dell’incidente. Ed è un senso di colpa in più, da sommare agli altri, nell’impietoso vortice di tormento che sa essere la vita.
Abiti dal taglio maschile, capelli raccolti e appena un filo di trucco per questa Camilla color ghiaccio cui fanno da contrasto le tinte autunnali a intermezzo di fotogrammi. Risalta, a tal proposito, la scelta di interrompere bruscamente le sequenze e fissare istanti di nero col presumibile intento di procedere a scatti, come del resto procede la stessa protagonista.
Di tanto in tanto, dalla finestra di fronte, si scorge una festante coppia di anziani. Ché la vita si diverte a sbatterti in faccia il futuro che non stai costruendo. Ma a rabberciarlo, prima ancora di Camilla, ci pensano compagni di viaggio del tutto estranei al suo universo di multinazionali. E i colori, di occhi e pose, che li introducono sanno essere squisitamente vivaci.
La figlia sa insegnare alla madre come si inseguono i sogni, come ci si rappacifica col passato, come il non detto inquina e la verità va sparsa una sera qualunque, tra un calice di vino rosso e una lacrima che può finirci dentro.
Bruno, il direttore dell’obitorio cui Francesco Colella, a dispetto della trasandatezza esteriore, sa assegnare affabilità e garbo inusitati, è un refolo di quiete (fare i conti tutti i giorni con la morte ti fa apprezzare la vita) e autenticità che si insinua nelle stanze buie di Camilla: buone solo, come in sogno, per annegarci dentro.
“Per me, recitare in questo film, ha rappresentato un processo di educazione sentimentale”. Francesco Colella
Un colpo di coda, poi un altro e un altro ancora. Infine la resa. Non fosse altro che per ghermire qualche istante di serenità, per ricominciare a sperare, per chiudere finalmente i conti con un passato che si apparenta col destino e diventa, per questa ragione, più tollerabile.
Pregevole, oltreché la capacità della Smutniak di attraversare una vasta gamma di registri recitativi, la scelta di accarezzare questo personaggio modellando il contorno a sua immagine e somiglianza: tutte le gradazioni del grigio nell’appartamento, il bianco dei meeting, il verde d’una domenica che Bruno le regala e che esaspera il gap tra quella di Camilla e le altrui vite, le luci calde e il rosso della determinazione d’una figlia.
E Soldini, confortato dalla diligente fotografia di Matteo Cocco, può così spostarsi sul fronte sensoriale dell’udito, cui arrivano rumori per nulla carezzevoli e per addolcire i quali si agisce meccanicamente, come nel caso delle scarpe tolte dentro casa.
La rinuncia a una colonna sonora invadente e la predilezione delle musiche del compositore Gianluigi Carlone ubbidisce allora all’urgenza di quella carezza che poi compendia questa pellicola d’una soavità esemplare, nonché rara.
Un cinema intimista, eppure tutt’altro che claustrofobico, quello di Soldini, il quale non si astiene dal lanciare un dardo sulla società che condanna all’invisibilità gli immigrati. Ed è allora che Camilla compie l’ultimo salto, quello necessario per restituire dignità a chi non c’è più, lasciare finalmente andare, perdonarsi, guardare un tramonto, sfiorare e poi coraggiosamente stringere una mano.